Dietro ogni canzone c’è una storia, e dietro ogni storia c’è una voce che sceglie come raccontarla. In questo caso, quella voce si chiama Dirlinger, un cantautore che si pone come obiettivo di raccontare, attraverso la musica, la realtà secondo i suoi occhi e le sue emozioni. Con una scrittura diretta, sensibile e uno stile che si rifà alla tradizione cantautorale italiana, Dirlinger ci accompagna dentro il suo mondo fatto di paure, nostalgia ed attualità.
“cOntastorie” non è solo il titolo del suo ultimo album, ma una dichiarazione d’intenti: un modo per prendere posizione e raccontare ciò che accade intorno – e dentro – di noi. Ogni brano è un tassello di questo percorso, che abbraccia temi universali come la paura, l’incomunicabilità e la violenza di genere.
Nel corso dell’intervista, Dirlinger ci racconta le origini del progetto, l’ispirazione che lo ha portato a scegliere un nome tanto particolare e il modo in cui si è avvicinato al songwriting come gesto intimo, necessario, quasi terapeutico.

Dirlinger è un nome interessante: chi è Dirlinger? Com’è nato e com’è arrivato a comporre
musica?
Nella mia famiglia non c’era nessuno che cantava, suonava o scriveva. Il primo incontro che ho avuto con la musica, e in particolare con la canzone d’autore, è stato alle medie, quando ci hanno fatto ascoltare La Locomotiva di Guccini, un brano che parla di un attentato anarchico. Questo pezzo mi ha folgorato per la storia che raccontava, e da lì ho iniziato ad approfondire il mondo della canzone italiana classica.
Verso i 13 anni ho iniziato a “strimpellare” la chitarra da autodidatta e, durante l’adolescenza, ho cominciato a usare la scrittura a fini autoterapeutici. Il lavoro in riviera, nell’ambito dell’intrattenimento, mi ha aiutato — per necessità — a creare un ponte con il pubblico. Questo si è riverberato, in maniera più definita, dopo il lockdown, quando ho deciso di iniziare a far ascoltare le cose che stavo scrivendo. Quando poi ho deciso di autopubblicare, scoprendo l’home recording, volevo nascondermi dietro un nome d’arte, poiché esso stesso può essere un messaggio di presentazione. Dirlinger, nel mio caso, nasce dalle leggende del folclore sudtirolese: durante una vacanza al lago di Carezza, ho letto delle storie riguardanti i “gnomi Dirlinger”, gnomi che scavano all’interno delle montagne. Mi sembrava una bella metafora per descrivere il lavoro del cantautore.
Hai uno stile ben definito (sia musicale che esterno), quasi nostalgico e molto italiano. Si nota
particolarmente nella canzone “Il mare in riviera”: è sempre stato così?
No, ero partito con un’idea che ho abbandonato nel momento in cui sono entrato nel mio studio. La canzone “Il mare in riviera” è nata dopo il primo singolo estivo, “Pantera di mare”, ed era volutamente macchiettistica. Ho calcato la mano su un immaginario nostalgico, a tratti felliniano. “Il mare in riviera” è un esempio di quelle cose un po’ demodé, un inizio, una canzone che si può ascoltare durante una serata di liscio romagnolo in una pensione a Bellaria.
cOntastorie è un titolo affascinante. Cosa significa per te essere un “contastorie”?
Sono una persona che scrive abbastanza. Col tempo — soprattutto dal lockdown in poi — mi sono ritrovato con canzoni scritte in momenti diversi, ma che in qualche modo seguivano un filo rosso, c’era qualcosa che le legava. La narrazione è diretta, scarna, quasi cronistica. Parlo di varie tematiche d’impegno sociale e di idee personali.
L’unione di questi pezzi, nati dal 2020 al 2024, ha creato l’album cOntastorie. Il titolo gioca sull’assonanza con la parola cantastorie: contastorie ribadisce come le storie raccontate siano sguardi e osservazioni sulla realtà circostante, chiaramente filtrati dal mio modo di scrivere e dalla mia sensibilità. Sono storie che ho rielaborato a modo mio. Nell’album ci sono varie sonorità, collegate da uno stile cantautorale.
Qual è stata la scintilla che ha fatto nascere questo album?
C’è stato un momento in cui mi ero stancato di fare le cose di cui parlavamo prima. Ho l’attenzione e la costanza di un bambino: tendo a fare tante cose, ma a stancarmi in fretta. La scelta di fare un album e pubblicarlo in blocco, senza rilasciare singoli prima, è nata proprio dal desiderio di rompere in modo netto con quanto fatto prima e con il modo tipico di operare dei musicisti indipendenti di oggi, che spesso sono mitragliatori di singoli.
Inoltre, l’idea di pubblicare un album nasceva dalla volontà di richiedere e pretendere un ascolto che andasse oltre i tre minuti di una canzone. L’album è piuttosto capitolato: si può ascoltare pezzo per pezzo, ma anche come un’unica narrazione, che si presta a varie sonorità e argomenti.
Penso che dovremmo essere noi, creatori di contenuti, a richiedere un impegno maggiore da parte dell’ascoltatore o del lettore.
Hai dei riferimenti artistici o letterari che ti hanno ispirato durante la scrittura?
A livello letterario e musicale mi ispiro molto al cantautorato degli anni ’70: tanto Guccini, tanto De Gregori. Molto folk, un po’ di blues, soft rock sempre anni ’70/’80. L’album è nato con l’idea di registrare, in maniera più o meno artificiale, un gruppo che suona: si parte da chitarra e voce, poi ho aggiunto batterie e basso e infine l’autoproduzione si è costruita attorno al brano. Quindi, tutto si sviluppava sul momento. Mi occupo di tutto, dalla scrittura fino al mastering.
Tutti i pezzi sembrano raccontare una storia con un tema ben preciso. Per esempio, “Ho Paura” parla chiaro: tratta un tema comune a tutti. Cosa vuol dire per te avere paura?
In questa canzone mi ci ritrovo molto, perché è forse il pezzo più personale dell’album. Ho deciso di includerlo perché, ogni volta che lo facevo ascoltare, molte persone si ritrovavano nelle frasi e nella canzone stessa. È una storia che appartiene a me, ma anche a chi mi sta intorno.
Nel testo ci sono cose di cui ho effettivamente paura, perché sono una persona che si lascia facilmente distrarre da ciò che la circonda, e quindi anche le cose che richiedono metodo diventano più impegnative. Ad esempio, la tecnologia è uno degli argomenti che mi spaventano molto. Questo brano è stato l’ultimo che ho scritto, proprio perché mi stavo interfacciando con nuove tecnologie che non comprendevo. Poi, pian piano, ho capito. Mi sentivo fuori dal tempo, e questo mi spaventava. Quando si ha paura di qualcosa, si può scappare fino a un certo punto. La paura della tecnologia, ad esempio, l’ho superata. Nell’album ci sono anche altri tipi di paura, come quella delle relazioni umane, l’incomunicabilità e la difficoltà di mettersi in relazione. Con tutte le difficoltà di portare avanti un progetto indipendente, di trovare realtà altrettanto indipendenti e costruire cose nuove, nasce il timore di perdere il contatto con la realtà, di chiudermi in una narrazione personale dentro cui mi racchiudo. Quella paura è ancora lì: c’era quando ho iniziato a registrare l’album circa un anno fa, e c’è ancora adesso.
Un altro pezzo particolare è “Oggi come ieri”, che sembra parlare di una routine senza fine che ci imprigiona un po’ tutti, chi più e chi meno. Pensi che anche nella musica ci sia una routine alienante?
Sì, anche se non ci avevo mai pensato. La routine c’è e si ricollega a ciò che dicevo prima: sta nel ripetersi o nel fare le cose semplicemente seguendo la scia di chi è venuto prima. Nel mio caso, mi è stato detto che sono andato avanti perché sono tornato indietro, però al di là di questo, non mi sembra di aver fatto nulla di particolarmente innovativo, magari dirompente rispetto alle modalità attuali. La routine esiste ed è poco stimolante: ci si mette tutti a fare le cose in un certo modo, senza lasciare spazio alla creatività o alle idee.
Per combatterla, cerco di essere sempre pronto all’ascolto, perché se ti metti all’ascolto sei creativo, entri in empatia con ciò che gli altri creano. Così, piano piano, qualcosa cambia, anche solo piccole sfaccettature.
Il singolo “Mafalda”: chi è Mafalda e che tipo di stori racconti in questo brano?
Mafalda non è un personaggio ben preciso: racconta, in realtà, tante storie. È nata mettendo insieme fatti e racconti tratti dai media. È una storia di violenza, che ha una doppia dimensione: da un lato, ritorna il tema dell’incomunicabilità, perché Mafalda è vittima di chi le sta attorno e non si rende conto del disagio che quella persona le porta, accentuato anche da mentalità chiuse e di paese. Dall’altro, la cosa positiva della canzone è che si possono cambiare i finali: qui Mafalda non finisce come troppe storie reali purtroppo finiscono. Nell’artificio della canzone, si può immaginare un lieto fine. Quindi, Mafalda si riscatta e si libera dei suoi aguzzini.
Mafalda, nel testo, sembra avere un’evoluzione: passa dall’essere “una stupida e una falsa” a “più bella e autentica”. Questo da quando trova l’amore all’università. Potrebbe essere che Mafalda sia rinata grazie a questa nuova relazione?
Sì, nel ritornello è la gente del paese a dire che Mafalda è stupida e falsa e poi cambia opinione perché “sembra più bella”. Sta all’interpretazione dell’ascoltatore. Potrebbe essere che Mafalda, in realtà, non sia mai cambiata, ma abbia semplicemente smesso di essere vittima di sofferenze, trovando qualcuno in grado di valorizzarla per quella che era. Oppure, potrebbe aver cambiato il suo atteggiamento.
Come autore, sento il dovere di trasmettere il messaggio che Mafalda non ha fatto nulla di male: è una vittima. Si parla di lividi, che sono sia psicologici che fisici. Secondo me, Mafalda non ha cambiato nulla di sé: ha semplicemente smesso di soffrire, iniziando a vivere un amore più sano.
Questo è, per me, il suo cambiamento.
“Mafalda” ha ottenuto un premio importante, il Premio Pigro: cosa ha significato per te vedere i tuoi sforzi riconosciuti ufficialmente?
È stato un onore, ma anche un onere. Il Premio Pigro è dedicato al grande cantautore Ivan Graziani, che è stato un narratore straordinario delle figure femminili. Per me è stato un doppio fregio. Ricevere questo riconoscimento ha posto l’accento non solo sulla canzone in sé, ma anche sul fatto che mi sia stato riconosciuto lo sforzo di inserirmi, a mio modo, in una tradizione. E questo, per me, è molto importante.
Come lavori solitamente: arriva prima il testo o la musica?
Per me arriva prima il testo, anche se spesso è già legato a un’idea di melodia che mi viene in mente. Mi immagino una sorta di testo canticchiato, poi con la chitarra ci costruisco attorno.
C’è un brano dell’album che senti più “tuo” degli altri? Perché?
In qualche modo tutte le canzoni raccontano punti di vista che mi appartengono, su vari temi come la violenza di genere, l’ambientalismo e altro. Forse un brano che ho sentito particolarmente mio, tanto da volerlo tradurre e inserire nell’album, è stato “Vincent”.
È una canzone famosissima degli anni ’70, che parla di Van Gogh e della sua pazzia, e torna al tema dell’incomunicabilità. Il mio lavoro è stato quello di traduzione e arrangiamento. Anche se il pezzo non è nato da me, lo sento molto vicino e sono felice del risultato.

Dopo cOntastorie, cosa ti aspetti o sogni per il tuo prossimo progetto?
Ho iniziato a fare delle pre-produzioni di progetti futuri. Vediamo se riesco ad allargarmi verso nuove situazioni. Quello che mi auguro è di non ripetermi. Se questo album si rifà alla tradizione folk degli anni ’60 e ’70, l’idea per il futuro sarebbe di trattare temi simili, ma con sonorità meno “datate”, magari più vicine all’elettropop o agli anni ’90.
Hai un messaggio che vorresti lasciare a chi vuole approcciarsi alla carriera musicale?
Io stesso mi ci sto affacciando adesso, cercando di capire come si muove questo mondo, che è sempre in evoluzione. Fino ai 20 anni, ciò che mi ha frenato nel fare musica è stato uscire dalla mia bolla vintage e provare a capire come gira oggi il mondo.
La cosa importante è fare rete: quando c’è qualcuno che ha voglia di farsi ascoltare — e voglia di ascoltare, che non viene mai in secondo piano —, insieme alla voglia di contaminarsi e conoscere, allora ci si dà ossigeno a vicenda. Cercate di girare, di ascoltare. Oggi si può rifare una tradizione, mettendoci dentro l’attualità.
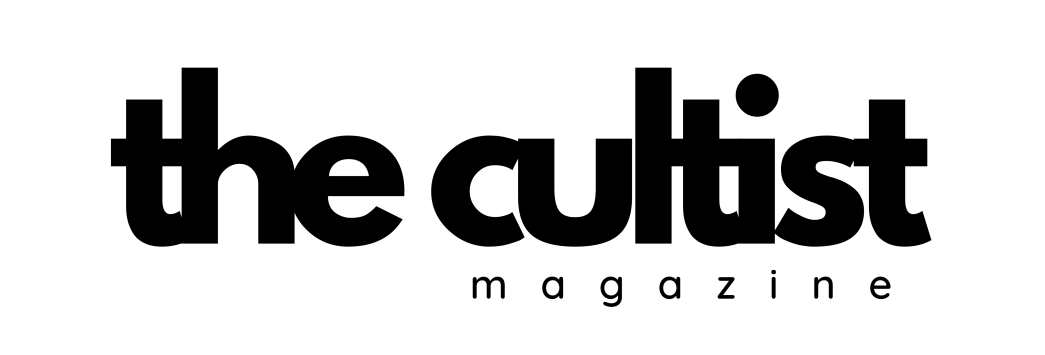
Lascia un commento